Storie di vite vissute nel Museo Bandini
Nel lasciare i suoi beni al Capitolo della Cattedrale – che avrebbe poi creato l'Opera Pia Bandini - il canonico Angelo Maria Bandini confidava certamente che fosse custodita memoria di quanto aveva voluto in vita, ovvero assistere i bisognosi, educare i giovani e consentire di godere della specialissima raccolta di opere d'arte, i primitivi, che aveva collezionato, primo ai suoi tempi. Gli studi hanno ormai da tempo messo in luce la peculiarità della sua raccolta d'arte, molto in anticipo, ad esempio, sull'altrettanto importante e nota di un altro uomo di curia come il cardinal Joseph Fesch, zio di Napoleone, che è andata a costituire il Musée Fesch di Ajaccio in Corsica.

Nuova attenzione si vuole invece rivolgere al luogo dove i fondi oro di Bandini sono stati conservati a partire dal primo Novecento.
Rivelatasi poco sicura la sede originaria della raccolta, a Sant'Ansano, nella quale le opere erano state ridotte per comporle in uno spazio modesto, la Curia decise di edificare un luogo più idoneo, sui terreni di sua proprietà contigui alla Cattedrale e alla Canonica, all'inizio di via Giovanni Dupré (Fig. 1).
Il progetto venne affidato a Giuseppe Castellucci, architetto di gran voga al tempo, che nel progetto rispettò il pensiero di Bandini, ovvero che ci fosse anche uno spazio per la Scuola domenicale di disegno, fondata da Bandini stesso e per lungo tempo diretta da Paolo Ricci, artista fiesolano, che del Castellucci era stato collaboratore.
Il primo progetto si dimostrò eccessivamente costoso e ne fu richiesto un secondo più sostenibile.
Inaugurato finalmente nel 1913, il museo fu concesso in gestione al suo costruttore, l'impresario edile Luigi Taiuti che avrebbe dovuto risarcirsi delle spese sostenute con la vendita dei biglietti, forse anche convinto dall'attenzione che il nuovo stato unitario aveva rivolto al patrimonio degli Enti Morali Ecclesiastici (Legge n. 364 del 20 giugno 1909). La Grande Guerra e la conseguente crisi economica non consentirono la realizzazione delle sue speranze e, dopo sofferte controversie legali, il Capitolo riprese possesso dell'edificio nel 1924, rimborsando il Taiuti con una cifra assai inferiore alle spese da lui sostenute. Il progetto prevedeva anche un appartamento per i custodi. Non sappiamo chi lo occupasse durante la gestione Taiuti, ma il Capitolo affidò la custodia dell'edificio in comodato alla signora Sani, moglie del fornaio di piazza Mino. L'appartamentino nel quale ella viveva con il figlio (e dove successivamente nacquero ben due nipoti, nel 1938 e nel 1942) occupava lo spazio del piano di accesso ed era diviso in quattro piccole stanze, due delle quali – oggi riunite nella sala che ospita la cosiddetta “Madonna del Brunelleschi” – erano affacciate sugli orti nel retro, ai quali però non aveva accesso.
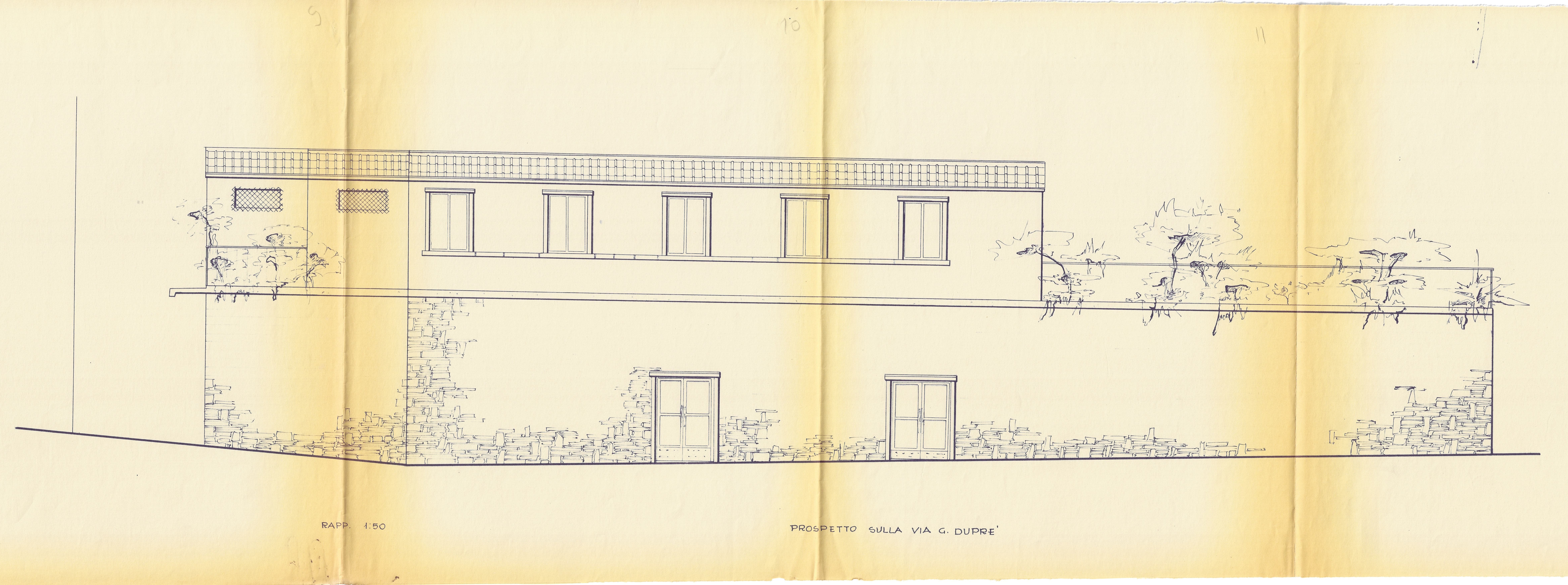
La custode teneva pulito, faceva pagare i biglietti ed eventualmente faceva da guida. La sottostante cantina negli ultimi tempi della Seconda Guerra fu utilizzata per nascondere beni di fuggiaschi, ma una soffiata fece arrivare qui gli occupanti tedeschi, che si portarono via quanto vi era stato riposto (ori e stoffe), ignorando le opere d'arte del piano di sopra, forse occultate da mobili che vi erano stati accantonati sempre dai fuggiaschi. La famiglia Sani fu costretta a lasciare l'alloggio e vi poté tornare solo dopo la Liberazione, anche se nel 1946, per motivi di spazio e di crescita della famiglia, vi rimasero solo la custode e il marito. Nel 1961 subentrò a questa la famiglia Baldanzi, giunta dal Mugello, grazie al conterraneo Monsignor Giustino Formelli, che confermò per i nuovi inquilini il comodato gratuito in cambio dei servizi. Questi vi abitarono per due generazioni, ricavando il 10% sui biglietti venduti: vi si succedettero prima il nonno e, alla sua morte, nel 1973, la nonna, e poi ancora la loro figlia, dal 1975 al 1988, finché la gestione non passò al Comune.

L'attuale Sala delle Robbiane, che prima della Grande Guerra ospitava la scuola di disegno, dopo il Secondo Conflitto Mondiale ospitò il Circolo Acli, con il relativo bar, che in metà della cantina conservava i propri rifornimenti. L'accesso al circolo era garantito da una porticina che si apriva sulle scale esterne, addossate all'edificio museale, le quali conducevano ad altre stanze, tra cui la sala del biliardo, un pallaio realizzato da Napoleone Banchi, una pista di pattinaggio e un giardinetto a terrazza, dove giovani e anziani giocavano a carte, tutti insieme (Fig. 2) Non va inoltre dimenticato che nei locali esterni all'edificio del Castellucci si riunivano anche gli Scout.
Alla condivisione degli spazi dal 1959 arrivò poi a partecipare anche la Democrazia Cristiana, in cerca non solo di una sede di partito ma anche di un luogo dove poter riunire iscritti e simpatizzanti e "ove si possa tenere un comizio o un'assemblea". Anzi, la sezione fiesolana della DC aveva ipotizzato un ampliamento dell'edificio e la costruzione di una sala convegni, mai realizzata. A quel punto la piccola porta fu chiusa e alla sala si accedeva dall'ingresso del Museo.
Dai ricordi dei nipoti dei custodi, Paolo Sani – che vi è nato – e Filippo Baldanzi – nato quando ormai si veniva al mondo nel non lontano Ospedalino di Fiesole – emerge tutta la reale affezione al luogo, espressa dagli adulti nell’offrirsi di buon grado come guide ai visitatori, in larga maggioranza stranieri, mescolando qualche termine orecchiato alla schietta parlata natia e invidiando le comitive che sfilavano davanti per andare a visitare "quei due sassi" dell’Area Archeologica, tanto meno belli dei fondi oro e delle robbiane. I piccoli di casa invece giocavano nelle sale espositive, soprattutto "conducendo" la portantina conservata al primo piano, che si vede ancora nelle foto del catalogo del museo curato da Maria Cristina Bandera (Fig. 3) e talvolta, a porte chiuse, anche a pallone tra le robbiane.
E il pallone non gioca un ruolo secondario: infatti la squadra dell'Acli, Novaradio Acli, ha partecipato al campionato di calcio di III categoria, così come la squadra della Fulgor, che condivideva alcuni giocatori della Fiesole Calcio, il cui allenamento presumibilmente iniziava e terminava al bar.
Ma la cultura non era trascurata. Da questa sede era seguita l'organizzazione di un premio di pittura, il "Mino da Fiesole", a partire dal 1963 e fino al 1972, anno in cui vinse un fiesolano, il pittore Giuliano Grassellini. Nella giuria sedeva fra l’altro Baccio Maria Bacci. Nell'edizione del 1967 furono presentate ben 520 opere e il premiato fu Bruno Rosai, nipote di Ottone. Ma gli stessi spazi ospitarono anche eventi atti ad attirare un pubblico più vasto, fra cui, nel 1967, la mostra mercato dei regali di Natale e una mostra di arte sacra. Tutte queste attività hanno quasi fatto dimenticare che il Museo, dopo l'ultima guerra, non riaprì fino al 1954 per i danni subiti (anche se limitati al lucernario e poco altro), segnalati al Sindaco Casini e alla Soprintendenza da Cesare Fasola, funzionario della Soprintendenza, nonché membro attivo del Comitato di Liberazione e poi assessore del Comune. Nuovamente chiuso nel 1987 per restauro – e soprattutto per il riordino delle collezioni – il Museo Bandini riaprì definitivamente solo nel 1990.
Laura Corti
Immagini:
Fig. 1: Esterno del Museo Bandini (immagine di repertorio).
Fig. 2: Prospetto del Museo su Via G. Duprè con il giardinetto a terrazza dove giovani e anziani giocavano a carte (ACF, Archivio della DC di Fiesole, Amministrazione, 37).
Fig. 3: Immagine dell'interno, sala al primo piano del Museo con dettaglio della portantina (da Fiesole: Museo Bandini a cura di Maria Cristina Bandera, 1982).
Bibliografia:
D. Brunori, Giovanni Bastianini e Paolo Ricci, Scultori fiesolani. Cenni Biografici, Firenze, Tipografia Domenicana 1906
M. C. Bandera, Museo Bandini, Firenze, Calderini 1982
L'Archivio della DC di Fiesole. Inventario, a cura di A. Frontani, con un saggio introduttivo di E. Capannelli, Firenze, Polistampa 2014.
Fonti orali:
Interviste a Paolo Sani, Filippo Baldanzi ed Emanuele Pellucci
